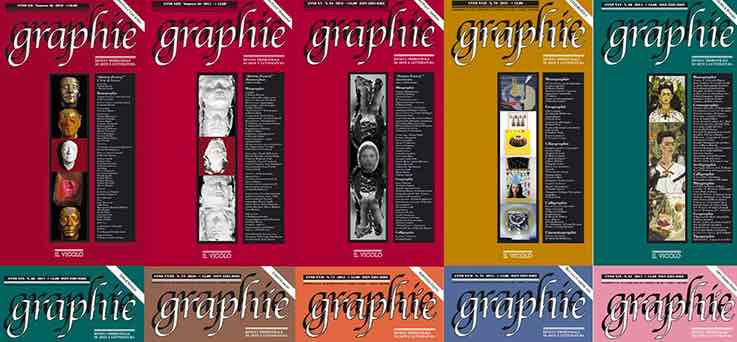da MonicaG | Mag 3, 2021 | recensioni
qui il link all’articolo completo su CASA MATTA nr.3 maggio 2021
recensione a Entro fuori le mura (Arcipelago Itaca, 2021) a cura di Milena Nicolini.
È una disamina della nostra società molto dura quella che Monica Guerra ci mostra nei versi di questa silloge. Senza permettere all’emozione di limitare la durezza della denuncia, trattenuta, sottesa, quasi compressa da un estremo prosciugamento della lingua, che arriva anche a forzarne la struttura, quando non ne complica pure il portato logico, con l’uso, ad esempio, di certi enjambement – una cifra stilistica della prima sezione – che polisemicamente possono aprire feconde ambiguità: “presto verrà l’autunno avvertivi / lasciando la mia mano sopra i nidi / d’agosto sorridevi / alla resa dei germogli / (…) / non è più la stagione dei germogli / ma l’arco fiorito delle tue ali ridevo / com’è giusto in mano / alla spina dei giorni disabitati”. Poesie quasi sempre molto brevi, ritmate da una sicura tessitura prosodica, dal respiro dei vuoti frequenti tra i versi, dagli ‘aparte’ sospesi degli incisi; poesie che lungo le quattro sezioni, introdotte da exergo non solo di grande spessore significativo, ma di apertura propedeutica, tagliano attraverso, incidono, sezionano la nostra attuale realtà di individui sociali. Significativo il titolo della prima sezione, La misura del vuoto, che rende immediatamente la tragedia attualissima della pandemia. C’è tutta la sorpresa, l’angoscia, anche la reticenza, l’incredulità del primo lockdown: “ma qui è sparare a raffica all’orizzonte”, “fuori è rovo”, “sporadiche razioni di luce e del resto / non vedere – poco importa –“, “quel parlare solo con i cani”. Di colpo il venir meno della convivenza con gli altri, addirittura l’essere esclusi, spostati “a lato” da una narrazione ragionata del presente che altri fanno, ma in cui si dà l’unico modo per esserci: “è la storia che ci tiene vivi, a lato / dieci centimetri di ponte”, che è lo spessore del muro delle case; dentro cui l’isolamento, la solitudine che scarnifica anche l’io: “il volto muore da solo”, non tanto per la mascherina, ma per un’identità non più confermata dallo sguardo dell’altro. Le reazioni sono di grande impotenza: “tu che mormori / il vuoto non esiste rampicando solitudine”, che ripeti come un mantra “un germoglio / è questa solitudine”, mentre vai “disertando sabbia alla clessidra”, in realtà ti accorgi che si accampa un altro male devastante: “-sempreverde / il ramo dell’indifferenza”, vero “diluvio quotidiano”, tanto che si devono accogliere “gli inciampi” come “doni / a piene mani”. E poi il grande dramma di coloro che vengono meno, spariscono di colpo , una devastazione nella già “spina dei giorni devastati”, appaiata alla morte vegetale per la terribile siccità. Pensare, vivere quelle morti solitarie: “immagino come un’isola / l’ultima carezza sotto le dita mentre / è solo il vuoto che le graffia” e dirsi che bisogna imparare, abituarsi “alla voce del verbo perdere”. È forse possibile intravedere uno spiraglio in un’assurda contiguità tra camera mortuaria e camera di un vecchio isolato che compie gli anni, in una casa protetta: mentre “il trapano” sigilla, ‘spegne’ “la bara”, la voce di una ragazza, che “per procura” soffia, “fuori dai vetri” che isolano il vecchio, su “novantadue candeline”, dice: “Bab, a t’fasè j’avguri”. Alla fine, dice la poeta, è la più vitale “liturgia per andare in pace”. Nella seconda sezione, Istantanee, si è fuori dalle mura di casa, ma dentro una ben più solida chiusura, quella dell’incomunicabilità. È un carosello di schizzi incrociati in giro, ma di quegli schizzi che con pochissimi tratti definiscono l’essenziale irripetibile. C’è subito, quasi a segno emblematico, l’assurdo paradosso per cui, volendo accedere alla “Charity” pubblica, ai barboni senzatetto viene fatto l’obbligo di fornire un indirizzo. Quindi è schizzata l’indifferenza di fondo nei rapporti apparentemente amicali; l’incomprensione reciproca dei bisogni, dei diritti degli altri; l’incomunicabilità fra culture e modi di essere vivi, per cui “- il tempo / è ringhiarsi l’un l’altro –“; l’impazienza verso i limiti, le necessità dell’altro, umano o animale che sia, che così viene strattonato, impedito, strofinato con malagrazia da chi dovrebbe aiutarlo. L’ossessione di far presto, dal traffico (molto potente immagine qui: “ i pickup si gonfiano ai semafori”) all’uomo che “assedia ogni minuto l’orologio”, in un affollarsi di figure non solo eterogenee, ma aliene nel loro proporsi ed interporsi, perché “tutti corrono d’intorno tutti sudati corrono / come lo avessero detto alla televisione”, secondo le regole di un conformismo che tutti rende burattini tra loro estranei. Ormai, infatti, c’è l’incapacità di stare insieme, al di là di un affiancamento da “isole mute… in arcipelaghi”. Anche nelle famiglie non c’è più capacità di comunicare: tra cani, figli, mogli, non riescono a darsi più niente, ognuno con una ragionevolissima giustificazione alla propria sovversione di un comportamento prestabilito, che l’altro non capisce, però, non tollera e reprime: il cane vorrebbe stare “un po’ in pace” all’ombra, il bambino non ha più fame per finire il piatto, la madre stanca non riesce ad entusiasmarsi alla “parvenza di vacanza” in collina e vorrebbe solo dormire, il padre, apparentemente ‘padrone’, nervoso perché cassaintegrato o senza paga. Significativi due altri schizzi: quello dell’atteggiamento dei famigliari verso il “bravo ragazzo” che chissà come e perché è caduto vittima di una qualche violenza da lui perpetrata su altri; l’incapacità di definirsi in sé e da sé da parte dei tanti che esistono quasi solo come foto, pensieri, corpi postati sui social. Nella terza sezione, La paralisi del giorno, domina la paura, l’incapacità di essere e di pensare diversi, l’immobilità nel conformismo. È una società, la nostra, ben recintata, dove “non un’orma fuori posto”, perché “ci sbriciola più del colpo / la tana della paura”. Solo fango tra le “paludi / immortali” di solitudini, vittoriose o perdenti che siano, perché non si danno conclusioni che si distolgano dal “ribadire noi i giusti / e qualcuno sempre contro”. Allora “l’occhio spranga le persiane” e si chiude nella “risacca del sonno”, impenetrabile dal vedere e dalla responsabilità, in un mondo hobbesiano dove homo homini lupus, al punto da chiedersi se la situazione sia segno di una tragica perdita o piuttosto l’inizio di una mutazione dell’uomo. Poi qualcosa la poeta lascia tralucere: “se l’albero si converte in croce”, la “linfa” vitale, nonostante tutto, si muove, e, non certo sulla spinta del “frutto proibito della paura”, “estirpa i chiodi dalla radice”. Così come smaschera il pericolo mortale del “canto” delle sirene –conformistiche, consumistiche, egoistiche, dico io – , che non si può credere di potere ‘godere’, assecondare, semplicemente legati come Ulisse all’albero maestro, perché quell’Itaca, a ben vedere, è solo un “pretesto” che sigilla il confinamento in un Limbo amorfo e nientificante. Ma il fatto è che il nostro mondo non ha più “eroi”, che i potenti vi restano sempre e comunque a galleggiare in situazioni di potere, che un falso utilitarismo ne determina valori e bisogni. Non c’è più “contempo”, il tempo assieme è troppo “difficile”; anche il futuro è vuoto di “aspettative”, chiuso com’è “l’orizzonte … nella tela di un ragno: “il passo per troppa esitazione” affonda e “si scioglie nell’asfalto”. Infine solo nell’ultima sezione, Nonostante, giunti proprio al limite estremo, quando per sperare bisogna arrivare a credere nell’ “impossibile”, si intravede un varco. Senza rinnegare che la vita è dura, che c’è sempre un vento pericolosamente capace di abbattere, si osa che bisogna imparare a “navigare i seni verdi dell’onda” per essere vivi, a vedere negli interstizi dei rami “la bellezza della zagara”, a cogliere il “calpestio” che viola il “cono d’ombra” dove “non arriva mai nessuno”, a sentire il bruciore vitale del sole, della parola, delle cose, “fuori”, anche quando “il gelo reclama una croce” e pare inchiodare ad un’immobilità di morte, e nonostante la tragedia ambientale provocata dall’uomo, nella sua “inversione / del fine con il mezzo”. La salvezza può essere solo nell’uscita dalla separazione incomunicante, dall’omologazione distruttiva. In fondo basta poco, magari imbattersi in pieno centro bolognese in un bar dove fintissimi enormi “bastoncini di zucchero” alle pareti e “casse /di bibite colorate” offrono un appiglio, se non per salvarsi dalla realtà (“la memoria non cicatrizza così”), per decollare almeno nelle lucine della “finzione”, che, chissà, delle volte eppure “salva la vita”.
e la voce le mille voci
la fioritura della pietra
restiamo dove
non è il tempo là dove
lo spazio non è cosa
deludiamo i confini
e miele dai seni di ciliegio
diveniamo l’altro,
la stessa cosa

da MonicaG | Apr 10, 2021 | pubblicazioni
è la vita/la liturgia per andare in pace
Cosa sono, cosa rappresentano le mura che Monica Guerra ci para davanti in caratteri corposi nella raffinata copertina della sua nuova opera di poesia? Evidentemente qualcosa di diverso da un muro, facilmente interpretabile come ostacolo, impedimento, opposizione, difficoltà, fisica o morale che sia.
Qui le mura hanno qualcosa di abbordabile, conciliante, un che di femminile che lascia immaginare, appunto, un dentro e un fuori con cui intessere relazioni, con cui interloquire. In realtà, a mio parere, il tema di tutte le opere di Monica Guerra, il senso che le attraversa sia pure nella loro specificità, è in definitiva quello del movimento, un movimento da e verso l’Altro, un viaggio continuo, irrinunciabile, resiliente per superare ostacoli, nodi intricati, per sconfiggere gli immobilismi, le chiusure. “Una forma di resilienza della vita stessa, ben oltre le fratture spesso indotte dalla fragilità umana”, come chiosa la stessa poeta nelle sue note ai testi della prima sezione, che accarezzano con autentica pìetasanziani, disabili, pazienti con problematiche psichiatriche. Perché?
La risposta mi pare semplice, intuitiva: perché ciascuno di noi si compie solo attraverso l’interazione con l’altro da sé, perché è solo rispecchiandosi nello sguardo dell’altro che si può riconoscere. Senza scomodare Lévinas, questa è esperienza quotidiana comune, a patto che la si sappia riconoscere, palesatasi con evidenza anche dolorosa in questo tempo di prolungato confinamento per difenderci dal Covid 19: insomma, perfino chi credeva con supponenza di poter bastare a sé stesso, s’è dovuto ricredere.
Così Monica Guerra ci racconta con delicatezza e per scorci di un’irruzione di volti che (la e ci) costringe a fare i conti con un’alterità difficile e tuttavia potenzialmente salvifica perché in grado di sottrarci alla nostra condizione meramente biologica, al nostro semplice egoistico dover esistere. Un’irruzione che può indurre timore, ma non paura; e il timore – si sa – non è che preludio di gioia.
Si vedano il testo I dedicato a Natalina (e così per te sale questa/primavera ogni voce priva/di un gesto sul fiato che si spacca) a cui fa eco il V, con la reiterazione del verbo spaccare, che risuona in ogni spazio bianco della pagina (ma io volevo salparti sul rituale delle nuvole/senza l’ombra di un’altra croce//implorando ancora un minuto/per abituarmi alla voce del verbo perdere//la liturgia della tua dolcezza/senza mani spacca in due il mondo), passando attraverso i testi II e III dedicati a Giovanni, “vivo per poesia”, per il quale un verso/sulla parete è il varco.
Fino a che punto – viene da chiedersi – è accettabile La misura del vuoto che dà il titolo a questa prima sezione del libro? E poi, si tratta di un vuoto per assenza da curare, si tratta di ferite da cucire e rimarginare? O, piuttosto, di un vuoto necessario e fecondo per ripartire anche a costo di un cambio di rotta? Parlare è sempre un po’ balbettare perché la complessità del nostro mondo interiore custodito nel silenzio non passa attraverso la lingua parlata. Ma la poesia può compiere il miracolo di attingere a questa zona muta e portare alla luce un vissuto, una sofferenza anche devastanti. La nostra poeta, incrociando queste persone, pare avvertire dietro lo sterno un crepitio che non può più contenere e allora mette in scena la sua umanità con un’opera di montaggio accurata e necessaria dove corpo e parola si confrontano e si sfidano fino a sgretolare ogni tentazione di dare spazio all’io lirico in vista di una grazia da conquistare.
In Sotto vuoto, Il Vicolo, 2016, Monica aveva lasciato intendere che l’esilio, come condizione metafisica, può essere riscattato dalla poesia che consente, almeno per barlumi, di intravvedere tracce di luoghi dove l’ordine perduto del mondo ha dimora; e, ancora, che viaggiare anche con il solo desiderio comporta un deragliare, un vibrare interiore (bere l’intero di ogni respiro senza sapere “cosa” ma sapere che sa di casa). Nel più recente Nella moltitudine, Il Vicolo, 2020, aveva ribadito che la poesia è un invischiarsi nella palude, un farsi contaminare per lavare le ferite e farle luccicare al punto da esibirne l’incanto e la fertilità (… lo sapevi maddalena che/amare un poeta è una palude ma sottovoce è un/chiodo che lava nel fango tutte le ferite; la distanza/non è un grido ma la misura della bellezza di/uno stame dalla sua radice).
In questo Entro fuori le mura (si noti la mancanza di congiunzione) il movimento continua per altre vie, facendosi viaggio, pellegrinaggio: un varcare la soglia di casa o, se vogliamo, di sé stessa per l’avventura che è la vita, se non la si vuole subire passivamente. E qui ci viene in soccorso l’etimologia delle due parole. Cos’è un pellegrinaggio se non un andare per agrum, cioè un attraversare campi superando ogni tipo di ostacolo – cosa non facile, evidentemente, cosa che può far gettare la spugna, spingere alla resa, anche se temporanea, anche se provvisoria -. Cos’è un’avventura se non un andare verso le cose che verranno, un proiettarsi senza rete verso un futuro che attrae, sul quale vogliamo investire, ignari su cosa potrà riservarci. Timore e tremore possono accompagnarlo, ma la spinta, la speranza sono così forti da persuadere alla partenza (chiedilo a un indizio di neve/niente è impossibile//nell’unità il punto zero esiste/fosse ripartire dalla cenere//e in questa notte a lato delle stelle/anche lo sterco esala un bagliore).
Monica Guerra lo fa in buona compagnia: sono poeti speciali, e meno frequentati rispetto ad altri, come Seamus Heaney, Rainer Maria Rilke, Charles Simić, Antonio Porta, Lucrezio, Peter Handke ad aprirle la strada nelle quattro sezioni del libro; ma concorrono felicemente all’impresa quattro immagini in bianco e nero di Virginia Morini, giovane e promettente fotografa d’arte, che hagià dato prove di grande spessore e originalità. Se ne La misura del vuoto la prospettiva pare essere quella di uno sguardo capovolto, in Istantanee pare di intuire che ad occhi chiusi si vede meglio. Se ne La paralisi del giorno la bellissima figura con schiena addossata ad una porta bianca, la cui parte inferiore del corpo sfuma nel nero dello sfondo, le mani solo apparentemente rilassate in grembo, sembra covare il desiderio di rialzarsi attraverso la luce che inquadra il viso ancora un po’ piegato e un movimento accennato appunto nelle piccole mani, in Nonostante, ultima sezione della ricerca, la figura esce dalla pagina spuntando obliqua da destra e occupando la scena, lo sguardo disteso, finalmente, tenero e determinato, le labbra appena schiuse di chi sa come procedere; vorrei aggiungere come un fiore che sboccia e si apre alla vita, correndo il rischio di essere leziosa.
Tutto in questa nuova silloge di Monica Guerra lancia segnali per orientarne la lettura, per marcare la soglia d’accesso alla parola: forme di paratesto meditate, misurate, imbastite con cura, non ultimo l’accurato e appassionato saggio di Sandro Pecchiari che si chiede e chiede a ciascun lettore “La finzione salva la vita?”. La risposta dell’autrice ci soccorre chiara nel testo finale Appendice: sì – la finzione a volte salva la vita –. Certo le ferite non cicatrizzano facilmente, ma può capitare anche tra le casse colorate di bibite o – aggiungo io – di fronte a una vetrina che espone in saldo un abito di perfetto arancione, di scorgere una via di fuga, un guizzo, se non di felicità, di leggerezza per procedere in libertà nell’avventura che è la vita.
Nadia Scappini

da MonicaG | Apr 7, 2021 | pubblicazioni
La raccolta Nella moltitudine (Il Vicolo, 2020) di Monica Guerra precede, nella produzione della poetessa romagnola, in ordine cronologico, Entro fuori le mura, il libro appena uscito con l’editore Arcipelago Itaca in questo 2021.
Nella moltitudine (che è anche il titolo di una famosa poesia di Wislawa Szymborska) è una raccolta che conferma la maturità raggiunta dalla scrittura di Guerra, ricca di immagini suggestive e profondamente evocative, in cui risalta un forte legame con le proprie radici.
La raccolta è suddivisa in quattro sezioni: Maddalene, La corrente del silenzio, Nella moltitudinee Nel conto alla rovescia, quest’ultima composta da brevi prose.
Scrive nella sua prefazione Francesco Sassetto:
“Colpisce la capacità di Monica Guerra di creare testi poetici e prosastici densamente allusivi e metaforici, a volte “visionari”, ma senza alcuna concessione ad orfiche oscurità né a scivolamenti autobiografici per quanto la scrittura sia impastata di esperienze vissute e dunque, concreta, materica, ancorata alla terra ed agli eventi dell’esistenza, come mostra bene l’alto tasso di occorrenze di vocaboli che si riferiscono ad oggetti, ambienti ed eventi della quotidianità e del paesaggio naturale, quel paesaggio che affonda le radici nella giovinezza tredoziese della poetessa.
qui l’articolo completo a cura di Enea Roversi

da MonicaG | Apr 7, 2021 | notizie
qui l’articolo completo
Piombino (LI) – Giovedì 8 aprile alle 21:15 in diretta Facebook sulla pagina della Biblioteca Civica Falesiana, si terrà il nuovo appuntamento dedicato alla poesia con la rassegna “Assaggi di parole”, organizzata dalla Biblioteca in collaborazione con l’associazione Assaggialibri.
Ospite dell’evento sarà Michele Paoletti affiancato dalla scrittrice e operatrice culturale Monica Guerra, che dialogherà con i poeti Fernando Lena e Francesco Sassetto a proposito dei loro ultimi libri: “Black Sicily” e “Il cielo sta fuori”, editi da (Arcipelago Itaca Edizioni nel 2020).
Monica Guerra a proposito del libro di “Sassetto” scrive: “Francesco Sassetto parte da ieri per dire con nitore l’indifferenza che caratterizza la contemporaneità, per individuare le conseguenze delle nostre attuali scelte sul domani – e delle precedenti sull’oggi – per destare, se non un cambiamento, almeno una nuova consapevolezza, forse un’assunzione di responsabilità”.
Dalla prefazione di Black Sicily di Francesco Tomada scrive: “Al di là della qualità della scrittura, che si traduce in un linguaggio teso e vivido ma non privo di epifanie sorprendenti e di dolcezze improvvise, quello che ancora una volta stupisce e impressiona nella poesia di Fernando Lena è il suo valore di verità. È infatti una poesia che non ha paura di sporcarsi le mani, di parlare di pizzo, di lampioni crivellati, di killer e di vittime, come se dapprima volesse disegnare una scena e poi, uno ad uno, inserire in quella scena i suoi protagonisti”.
Gli incontri si svolgeranno sulla pagina Facebook della Biblioteca Civica Falesiana: https://www.facebook.com/BibliotecaPiombino a partire dalle 21.15.
Gli spettatori potranno intervenire commentando in diretta.